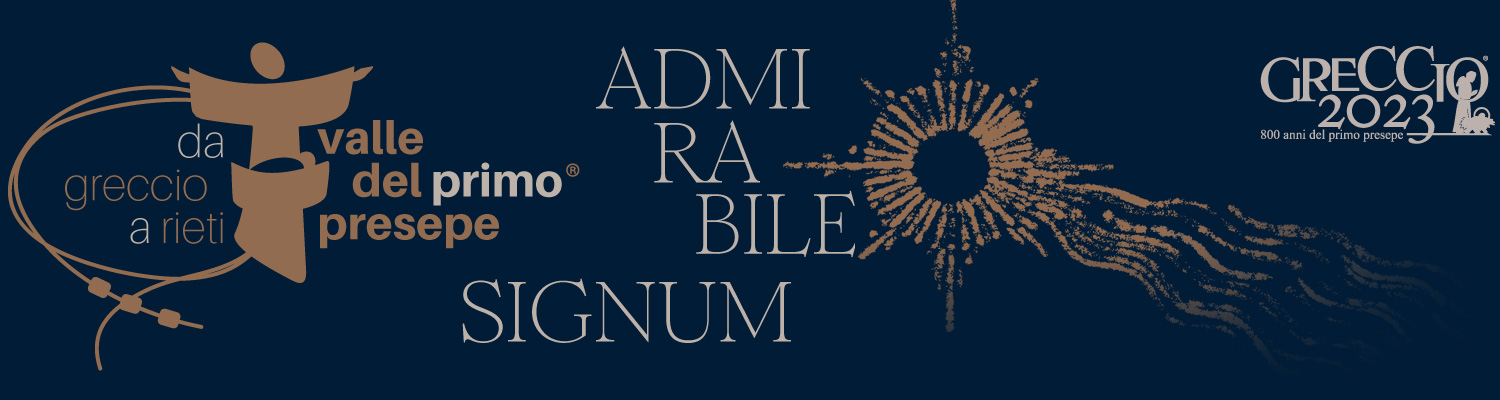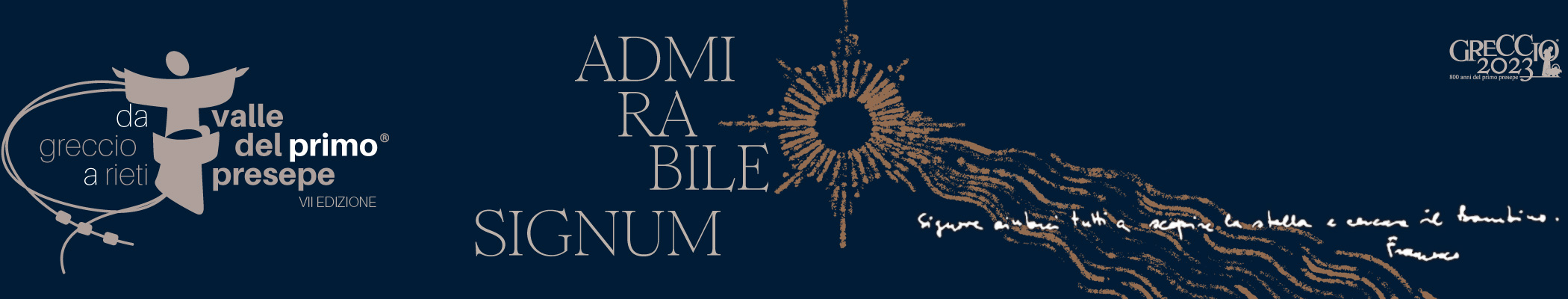Bücherverbrennung. Totale abbruciamento dei libri. Olocausto librario. Una parola ardente eppure oscura, un Roveto dell’Oreb al contrario: una scena orribile che rinvia ai peggiori aspetti degli Auto de fe inquisitoriali, ai ragazzacci squadristi di Gerolamo Savonarola che accendevano per le vie di Firenze i “roghi delle vanità”, ai riti notturni degli studenti in camicia bruna dinanzi alle università tedesche in quell’inverno del ’33, all’incubo magistralmente evocato da François Truffaut in Fahrenheit 451. Quando pensiamo a queste cose, risuona sempre dentro di noi la massima cupamente profetica di Heinrich Heine: chi brucia i libri è capace anche di bruciare gli uomini, e prima o poi lo farà. Nel 1266 l’ormai cinquantaduenne Luigi IX re di Francia, devoto di Francesco d’Assisi, stava consolidando il suo regno e rinnovando la sua capitale mentre pensava alla sua futura crociata; e suo fratello minore Carlo d’Angiò, ormai investito re di Sicilia, aveva battuto il rivale Manfredi di Svevia nella battaglia di Benevento e stava fondando in Italia le fortune della parte guelfa. In quell’anno, appunto, il quarantanovenne Bonaventura da Bagnoregio, che nove anni prima aveva dovuto rinunziare alla cattedra parigina di teologia perché eletto ministro generale dell’Ordine dei Minori, si trovava a dover fronteggiare le numerose istanze ereticali che stavano serpeggiando per l’Europa, nonostante la recente repressione del movimento cataro.
All’interno dell’ormai vastissima famiglia francescana doveva gestire l’inquietudine dei rigoristi che invocavano un “ritorno” al magistero del Fondatore, i cosiddetti “Spirituali”, e si rifacevano al suo esempio per contestare l’accordo profondo che sembrava regnare tra i capi del loro sodalizio e la Santa Sede e minacciava il genuino messaggio del Povero d’Assisi. Frattanto, i professori parigini della Facoltà delle Arti avevano dato vita a una lucida e robusta tendenza ispirata al radicalismo aristotelico qual era sostenuto dal grande commentatore Averroè. Bonaventura aveva già reagito alle molteplici visioni che circolavano a proposito della vita e della testimonianza di Francesco, appoggiate anche a numerosi racconti agiografici oltre che alle leggende e alle tradizioni, redigendo cinque anni prima una sua nuova biografia, distinta in due versioni: maior e minor. Scopo di quel testo era la definitiva normalizzazione del racconto delle vicende connesse con la vita e il culto del santo: ma la polemica causata dalle molteplici voci a ciò relative continuava. Per troncarla, nel Capitolo dell’Ordine convocato appunto nel 1266 a Parigi, il ministro generale non solo impose l’adozione del suo testo come ufficiale e definitivo, ma dispose altresì che tutti gli altri che parlavano del medesimo argomento fossero dati alle fiamme. Sarebbe stato difficile obbedire, anche se tutti avessero voluto farlo: e molti non vollero. Per disobbedienza, ma anche per la difficoltà obiettiva a reperire tutti gli scritti di quel tipo, molti di essi in un modo o nell’altro sopravvissero e continuarono a circolare. Ne sarebbe scaturita, a partire del XIX secolo, quella “questione francescana” che ancor oggi perdura e che ha riempito intere biblioteche.
Qual è mai il ”vero” Francesco? La versione della vita di Francesco elaborata da Bonaventura sarebbe rimasta da allora “canonica”, sebbene spezzoni di altre voci continuassero a circolare (ne sono prova le raccolte di racconti come i trecenteschi Fioretti, che contengono anche pagine arditamente antibonaventuriane). Ma da allora le vicende dell’Ordine – quindi il cosiddetto “minoritismo” – prevalsero su quelle del Fondatore almeno fino al 1894 allorché l’edizione della Vie de François d’Assise del protestante Paul Sabatier, allievo di Ernest Renan, accese polemiche e dette luogo a nuovi studi che, fino a oggi, continuano appassionatamente. Ne è prova il lavoro di una studiosa schiva e appartata ma rigorosa, Chiara Mercuri, col suo Francesco d’Assisi. La storia negata (Laterza, 2016), che pur avendo avuto un buon successo editoriale non è stato forse considerato dagli specialisti con la dovuta attenzione: forse perché “scomodo”. Ma il problema rimane. Chi era il “vero” Francesco? Ed è possibile arrivare sul serio alla “verità” storica? E in quali modi, secondo quali metodi, fino a che punto? In tempi di “controstoria” di storia “virtuale” e “ucronica” oppure “alternativa” , di postverità – o, per contro, della difesa talora isterica di verità ritenute incontrovertibili dall’assalto dei “revisionismi” – la questione è divenuta scottante. E ci si è accorti altresì quanto forte fosse, anche in passato, il peso delle fake news.
E’ proprio qui che sul nostro generale problema s’innesta non già un “romanzo storico” propriamente detto, bensì un mosaico polisignificante di varie possibili interpretazioni di “cose”, di “fatti” nella loro forma esteriore già appurati o tali ritenuti. Massimiliano Felli, romano quarantenne, già professore liceale di lettere, oggi funzionario di banca (in termini di stipendio, ci ha guadagnato), non ha per fortuna mai dimenticato i suoi studi e la sua passione per la scrittura. Ora, col romanzo Vite apocrife di Francesco d’Assisi (Fazi, pagine 371, euro 17), ha pazientemente composto un puzzle di fonti disparate mostrando, come fece Akira Kurosawa col film Rashomon, la pluralità delle “verità” possibili e l’inattendibilità di testimonianze date per sicure. Lineare l’impianto romanzesco, ovviamente di fantasia. Il segretario di Bonaventura, fra Deodato, riceve l’incarico di consegnare alle fiamme tutte le testimonianze della vita di Francesco diverse da quella redatta dal suo maestro: ma, in preda al dubbio e alla disperazione, decide di disubbidire. Si mette allora in cammino alla ricerca dell’ultimo, scomodissimo, vero superstite tra i compagni del Povero d’Assisi, un frate Leone invecchiato e inebetito, apostata e visionario.
Da lui riceve una serie di racconti contraddittori, qualcuno imbarazzante e scandalizzante, sull’uomo che la Chiesa ufficiale del tempo saluta come il rinnovatore e il salvatore della cristianità mentre ne perseguita i più fedeli seguaci o quanto meno coloro che tali credono o pretendono di essere. Il romanzo ci conduce quindi fra le strade e le piazze dell’Italia duecentesca, nell’incanto di paesaggi di giottesca bellezza, alla ricerca di una verità che non si scoprirà mai e alla scoperta di molte altre verità insospettate. Se questo fosse un romanzo storico, qualche critica andrebbe forse mossa all’eccessiva invasività, sovente antistorica e magari, nel linguaggio, qua e là anacronistica di alcuni dialoghi e di alcune situazioni. Ma il punto è che questo è semmai per certi versi uno psicoromanzo, per altri una specie di “poliziesco”: una non proustiana ricerca “del Francesco perduto”.
Di Franco Cardini per Avvenire